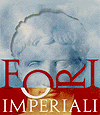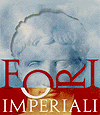I Fori Imperiali
Foro di Nerva
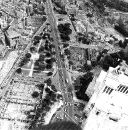 Lo scavo del Foro
di Nerva, condotto dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali del Comune di Roma e considerato
il primo grande intervento archeologico nell’area centrale della città dal
dopoguerra ad oggi, si è concluso nel 1996, dopo aver conseguito eclatanti risultati dal
punto di vista scientifico e un enorme interesse tra il pubblico di visitatori, italiani e
stranieri che hanno potuto visitare l’area di cantiere durante le visite guidate
curate dalla Sovraintendenza. Lo scavo del Foro
di Nerva, condotto dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali del Comune di Roma e considerato
il primo grande intervento archeologico nell’area centrale della città dal
dopoguerra ad oggi, si è concluso nel 1996, dopo aver conseguito eclatanti risultati dal
punto di vista scientifico e un enorme interesse tra il pubblico di visitatori, italiani e
stranieri che hanno potuto visitare l’area di cantiere durante le visite guidate
curate dalla Sovraintendenza.
Viene offerto agli utenti di
questo sito Internet un ampio excursus dei recenti ritrovamenti nel Foro di Nerva, il
primo intervento per la costituzione del Parco archeologico dei Fori Imperiali.
 Con orgoglio possiamo oggi
affermare di aver portato in luce nell'area archeologica centrale una importantissima
successione di fasi storiche della vita di Roma, stratificatesi ininterrottamente dal II
sec. a.C. sino al 1930 e perfettamente visibili e comprensibili all'interno del Foro di
Nerva, dove oggi le cantine degli antichi edifici rasati al suolo durante i lavori
di apertura di via dell'Impero, custodiscono al loro interno murature di età precedenti
inglobate in quelle moderne e, in veste di naturale antiquarium del Foro, conservano in
attualissme teche alcuni dei ritrovamenti più significativi di tutte le fasi riscoperte. Con orgoglio possiamo oggi
affermare di aver portato in luce nell'area archeologica centrale una importantissima
successione di fasi storiche della vita di Roma, stratificatesi ininterrottamente dal II
sec. a.C. sino al 1930 e perfettamente visibili e comprensibili all'interno del Foro di
Nerva, dove oggi le cantine degli antichi edifici rasati al suolo durante i lavori
di apertura di via dell'Impero, custodiscono al loro interno murature di età precedenti
inglobate in quelle moderne e, in veste di naturale antiquarium del Foro, conservano in
attualissme teche alcuni dei ritrovamenti più significativi di tutte le fasi riscoperte.
La suggestione immediata di
questo primo tratto di un ben più ampio e affascinante percorso della memoria verso il
futuro, che è rappresentato nell’immediato dall’ormai prossimo anno 2000, è
indubbiamente per gran parte costituita dalla stretta analogia spesso riscontrata tra le
fonti storiche, particolarmente prodighe di notizie concernenti l’area dei Fori
Imperiali , ed i ritrovamenti nel Foro di Nerva.
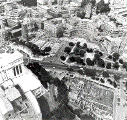 Un primo esempio notevolissimo di
corretta interpretazione attraverso i dati archeologici di proposizioni trasmesse dagli
storici antichi, si è potuto evidenziare nell’area meridionale del Foro, al confine
con il Foro Romano. Un primo esempio notevolissimo di
corretta interpretazione attraverso i dati archeologici di proposizioni trasmesse dagli
storici antichi, si è potuto evidenziare nell’area meridionale del Foro, al confine
con il Foro Romano.
Voluto da Domiziano e dedicato poi da Nerva, ma noto dalla tarda antichità come Foro
Transitorio, il Foro di Nerva sorse sul sito dell’Argiletum, l’antico quartiere
di età repubblicana diviso in due settori dall’omonima strada, che fin dalla prima
età repubblicana congiungeva il Foro Romano con la Subura, da sempre il più popoloso e
popolare quartiere di Roma.
Un intervento archeologico
effettuato nel corso del 1995 nell’area tra la Curia, la basilica Emilia ed il lato
meridionale del Foro di Nerva, aveva già evidenziato una serie di dati importanti
relativamente all’organizzazione del quartiere.
In quell’occasione, infatti, furono rinvenuti due ampi tratti di pavimentazione a
lastre di peperino databili al III secolo a.C., ma con evidenti restauri di età augustea,
riferiti al Macellum, il grande mercato della Roma repubblicana i cui edifici commerciali
dovevano essere però concentrati soprattutto nell’area posta sulla destra della
strada, in seguito occupata dal Templum Pacis, il Foro voluto dall’imperatore
Vespasiano tra il 71 e il 75.
Lungo il settore sinistro, invece, le fonti storiche avevano sempre definito
l’esistenza di un quartiere con spiccata caratteristica residenziale composita,
costruito infatti soprattutto da ricche Domus appartenenti a potenti personaggi
dell’aristocrazia senatoria, ma anche con caseggiati di affitto.
E' certamente suggestivo ritenere
di poter identificare proprio con le case ricordate dalle fonti alcuni dei ritrovamenti
rinvenuti durante lo scavo nei livelli relativi a tale periodo, che pur essendo di enorme
interesse si sono potuti però raggiungere per ora solamente in tre settori del Foro di
Nerva.
In particolare nei siti sinora
indagati sono state individuate strutture ipogee cui si accedeva per mezzo di scale, delle
quali una è ancora in situ, sempre articolate in corridoi con muri in opera incerta e
pavimentazione in opus spicatum, lungo i quali si aprivano una serie di piccoli
ambienti, alcuni con pavimentazione a mosaico.
Sia la tipologia dell’impianto sia la presenza di lucernari , cancellate in ferro con
chiusura per le porte e di nicchiette nelle pareti per l’inserimento di giacigli
lignei hanno portato all’identificazione degli ambienti con resti di Ergastula,
i microscopici alloggi costituiti da una sorta di cellette chiuse a grate, nei quali
venivano alloggiati gli schiavi impiegati per il funzionamento delle ricche domus.
Uno degli ergastula è stato completamente scavato in modo tale da fornire
un’esemplificazione a tutto tondo della realizzazione e della successione degli
ambienti inseriti nel complesso edilizio.
Ad un primo esame,le strutture
sembrano appartenere a due fasi cronologiche diverse: la più antica databile agli ultimi
anni del II secolo a.C., in base allo stile dei mosaici pavimentali, mentre la successiva
sarebbe da inquadrare nella prima metà del I secolo a.C.
La tipologia stessa dei mosaici ha suggerito che nella prima fase l’edificio
rinvenuto deve essere ricondotto ad una diversa organizzazione dell’impianto. Un
primo pannello, infatti, di forma quadrata rappresenta ben evidenziata una figura maschile
itifallica in atto di nuotare, affiancata ad un grande animale marino, una raffigurazione
ibrida tra un delfino e una balena. Di buona fattura e con evidenti rappezzamenti in età
antica, il mosaico conserva inserti marmorei colorati, mentre il secondo tappeto musivo in
bianco e nero, di forma rettangolare, presenta la tipica raffigurazione di mura civiche.
Infine sono stati rinvenuti
cospicui frammenti di pannelli a mosaico con motivi geometrici e vegetali, nonché una
serie di tombini per il deflusso dell’acqua, che hanno suggerito l’inquadramento
dell’edificio nella prima fase di vita ad una complessa scansione di spazi,
comprendenti forse anche un piccolo edificio termale.
Non si è neppure esclusa l’ipotesi che almeno una serie di tali sotterranei potesse
aver fatto parte del Macellum, con gli ambienti ipogei comunque destinati agli
schiavi pubblici, impiegati di giorno nella vendita al mercato.
E’ noto che il progressivo
processo di trasformazione del settore meridionale dell’Argiletum portò alla
sostituzione delle case e delle strutture commerciali con una serie di grandi complessi a
carattere pubblico, culminati con la costruzione dei Fori di Cesare e Augusto.
Tuttavia ancora una volta le fonti storiche, prima ancora del supporto della
documentazione archeologica, sono concordi nel ricordare che dopo l’incendio del 64
d.C. si giunse ad un preciso piano di riorganizzazione generale dell’area occupata in
origine dall’Argiletum, predisponendo il sito verso un nuovo ed esteso progetto
urbanistico, che i nuovi dati acquisiti dopo lo scavo attribuiscono allo stesso Nerone,
novello architetto della nuova città, come ci hanno tramandato i racconti di Tacito,
Suetonio e Cassio Dione.
In passato l'esistenza di un
tempio dedicato a Giano era stata conclamata dopo la scopera di un segmento di fondazione
posta lungo il lato breve del Foro, esattamente al confine con il Foro Romano.
L’evidenza archeologica ha invece indotto a ritenere che le enormi fondazioni delle
quali oggi si è rimesso in luce l’intero perimetro, siano da attribuirsi ad una
prima fase progettuale del Tempio di Minerva, erroneamente ipotizzato da Rabirio,
l’architetto di Domiziano, proprio al confine con la Basilica Emilia.
In tale posizione il tempio avrebbe ostruito gran parte dello spazio della piazza forense,
ma soprattutto avrebbe negato la possibilità di privilegiare l’asse longitudinale
Foro Romano-Subura, che invece avrebbe consentito di configurare il Foro domizianeo come
l’unico accessibile da tutti gli altri già esistenti. Infatti, una volta obliterate
le fondazioni della prima fase templare con la sovrapposizione della pavimentazione della
piazza e attraverso la costruzione del Tempio sul lato settentrionale, dove ancora è
visibile il podio, Domiziano poté realizzare una perfetta centralizzazione sul suo Foro
di quelli di Cesare, Augusto e di Vespasiano, nonché dei monumenti ad essi pertinenti.
E’ suggestivo ritenere che il Tempio di Giano possa invece trovarsi al centro del
Foro, sotto l’attuale via dei Fori Imperiali, ideologicamente al centro del nuovo
ordinamento politico e urbanistico realizzato da Domiziano.
In seguito diverse vicende
storiche hanno visto l’area forense alternativamente al centro di importanti
insediamenti altomedioevali o campagna malsana e paludosa.
Durante lo scavo non sono stati rinvenuti strati di crollo o di abbandono riferibili al VI
e al VII sec. d.C., i cosiddetti "secoli bui" visti sempre in chiave di
decadenza, mentre sono stati rimessi in luce resti di un grande edificio porticato eretto
direttamente sul livello della piazza antica e costruito con materiali di reimpiego,
datato alla fine dell'VIII sec. d.C. (16-17-18).
Resti di altre strutture
edifiacte con la stessa tecnica rimangono anche sul lato opposto, delimitando in tal modo
una strada che in epoca tarda prese il nome di Fundicus Macellorum de' Archanoè
(19-20-21). Si tratta di preziose testimonianze relative ad un momento di grande impegno
edilizio e se la scarsità di conoscenze sull'edilizia civile dell'epoca rende difficile
lo studio dei ritrovamenti, appare comunque indiscutibile l'intento di monumentalizzare
l'area con edifici di prestigio.
L'età carolingia, testimoniata a
Roma per l'edilizia civile esclusivamente dai ritrovamenti nel Foro di Nerva, sembra
delinearsi anche nell'area dei Fori Imperiali come il momento in cui si perde l'assetto
urbanistico ereditato dalla città antica e si tracciano le linee attorno alle quali si
articolerà la città medioevale.
In seguito, un'altra sistemazione
urbana mutò definitivamente l'aspetto del quartiere: durante il pontificato di Pio V, tra
il 1566 e il 1572, il Cardinale Bonelli fece bonificare la zona divenuta malsana a causa
delle continue fuoriuscite della cloaca massima con la costruzione di un sistema fognario
di grande solidità.
La grandiosità dell'intervento è tuttoggi testimoniata da due impotranti costruzioni: il
grande acquedotto posto al centro della via della Croce Bianca, denominazione moderna del Fundicus
Macellorum de Archanoè, che a sua volta ricopriva il percorso dell'antico Argiletum,
e il grande "Chiavicone", che fu realizzato scavando nell'area del Foro di Nerva
dal settore meridionale verso quello settentrionale.
Il grande condotto fognario
seguiva un percorso parallelo a quello dell'Argiletum ma ad una quota più alta e
utilizzava in gran parte materiali di recupero provenienti dagli edifici del Foro.
Dalla magnificenza della
costruzione e dalla portata d’acqua che poteva contenere non è difficile immaginare
di quale imponenza fosse il complesso fognario nel suo insieme, tuttavia l’importanza
del ritrovamento è anche di diversa natura.
Infatti, la strategica posizione del Chiavicone ha consentito, a scavo ultimato, di
restituire sia pure al di sotto della via dei Fori Imperiali, l’unitarietà del
tessuto urbanistico delle piazze imperiali che la costruzione di via dell’Impero
aveva definitivamente sconvolto ed ha segnato un momento di grande rilievo anche in
relazione alla sistemazione definitiva dell’area che dal Foro Romano giunge sino alle
aree forensi imperiali.
Il grande condotto fognario, infatti, una volta svuotato dai detriti che lo rendevano
impraticabile, costituisce oggi l’unico percorso che alla quota antica congiunge non
solo i due settori del Foro di Nerva, letteralmente sezionati dalla viabilità moderna, ma
consente anche ai visitatori che attualmente entrano nel Foro Romano dall’Arco di
Tito di raggiungere, seguendo il percorso della via Sacra, il Foro ormai completamente
rimesso in luce ed infine, grazie al Chiavicone perfettamente adattato e sistemato, di
entrare anche nelle altre piazze forensi senza soluzione di continuità.
Al termine della realizzazione
del Progetto Fori Imperiali in corso attualmente, saranno finalmente rimesse in luce tutte
le aree forensi e dal Colosseo sino a Piazza Venezia, tra il Foro Romano e i Fori
Imperiali, si verrà a costituire un Parco archeologico unico al mondo, sul quale potrà
continuare a vivere anche la via dei Fori Imperiali, elemento urbanistico ormai
storicizzato, che contribuirà come passaggio sopraelevato a sottolineare il fascino della
ritrovata unitarietà del sito antico.
Il tempio sul fondo del Foro, dedicato a Minerva
(divinità protettrice di Domiziano), sopravvisse in buono stato di conservazione fino al
1606, quando venne fatto demolire dal Papa V per utilizzare i suoi materiali per la
costruzione della Fontana dell’Acqua Paola sul Gianicolo. I recentissimi scavi del
1995-96 hanno mostrato che il Foro si impiantò in una zona precedentemente occupata da
edilizia residenziale, andata completamente distrutta nel terribile incendio del 64 a.C.,
e che la sua sistemazione definitiva venne preceduta da almeno altre tre fasi di
monumentalizzazione, probabilmente mai portate a termine, l’ultima delle quali
prevedeva la costruzione di un grande tempio sul lato verso il Foro Romano, opposto quindi
a quello che venne poi costruito.
> Serie di
immagini e fotografie inedite relative al Foro di Nerva
> Foro di Augusto
> Foro di Cesare
> Foro della Pace
> Foro di Traiano
> Mercati di
Traiano
> Presentazione
dell'operazione
> Metodologie di
recupero
> News dal cantiere
dei Fori
> Lo staff impegnato nel
recupero |