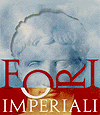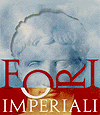I Fori Imperiali
Foro della Pace
71 a.C. – Vespasiano fa costruire il
Foro;
75 d.C. – Dedica del Foro;
192 d.C. – Incendio devastante sotto l’imperatore Commodo;
205-208 d.C. – Anni della realizzazione della Forma Urbis;
208-211 d.C. – Settimio Severo restaura il Foro e vi fa esporre la Forma
Urbis Romae;
V sec. D.C. – Nuovo incendio e abbandono del Foro;
526-530 – L’angolo meridionale del Foro è trasformato nella chiesa dei
Santi Cosma e Damiano;
1903: in Campidoglio si espone per la prima volta la Forma Urbis su uno
schema grafico di R. Lanciani.
Il complesso dei Fori Imperiali era idealmente
chiuso verso sud-est dal Foro della Pace, dedicato da Vespasiano e destinato inizialmente
a contenere il bottino proveniente dalle guerre giudaiche, nonché alcuni capolavori
dell’arte greca.
Il fatto di non essere menzionato tra gli edifici con funzioni eminentemente civili ha
spesso indotto a ritenere il complesso monumentale non proprio un Foro, cosicchè fino al
tardo Impero venne più semplicemente definito Templum Pacis.
Sul fondo del Foro, infatti, si apriva un tempio che si estendeva sino alla collina della
Velia, distrutta negli anni Trenta per costruire la Via dell’Impero e sulla quale era
stata eretta nel IV secolo la Basilica si Massenzio.
Il tempio era costituito da una grande aula absidata, che si apriva come un’esedra
sul fondo del portico; nella sua abside era conservata la statua di culto.
Una fila di colonne distingueva il portico dal tempio e un grande frammento in marmo
africano di una di esse è ancora visibile nell’aiuola davanti all’attuale
ingresso del Foro Romano.
Infine, nel 211 d.C. venne collocata in una delle grandi esedre del portico una mappa
topografica di Roma incisa nel marmo. All’interno del Foro era conservata anche una
Biblioteca, la cui planimetria ricorda quella di Adriano ad Atene, dove erano collocate
numerosissime opere d’arte, tra le quali Plinio il Vecchio ricorda quelle trafugate
da Nerone per la Domus Aurea, provenienti dalla Grecia e dall’Asia Minore e che
Vespasiano aveva invece restituito alla godibilità dei cittadini.
Funzioni
Lo schema costruttivo del Foro e il suo carattere quasi di ‘museo’ hanno indotto
inevitabilmente a ritenere che fosse utilizzato soprattutto come una raffinatissima sede
di rappresentanza, cosa che accadde poco tempo dopo per il Foro di Traiano, con una ben
precisa connotazione culturale.
Altre analogie notevoli con il Foro di Traiano , l’impostazione della piazza absidata
sul fondo del Portico e la statua di culto posta proprio nell’abside, suggeriscono
che alla base del progetto di Vespasiano vi fosse una anticipazione del definitivo
mutamento dell’edilizia nei Fori, destinati con Traiano ad affermare l’immagine
del potere assoluto dell’imperatore. La presenza poi della Biblioteca collegata al
tempio ricorda il sistema dei Principia, piazze forensi all’interno degli
accampamenti militari, nei quali, però, le biblioteche erano destinate a contenere gli
atti dei magistrati.
Non si può dunque escludere la funzione civile del Foro, rimandando agli ulteriori
interventi di scavo archeologico il compito di chiarire la complessa interpretazione dei
dati finora emersi.
Contesto storico
Il tema proposto da Vespasiano nel suo Foro, quello della pacificazione scaturita
dalle vittorie belliche, pur non discostandosi da quello di Augusto e Nerva, trova la sua
più alta espressione proprio nel Foro della Pace, dove la Pax è il simbolo stesso del
complesso monumentale.
Naturalmente la decorazione architettonica e l’intero programma figurativo del Foro
non potevano che essere legati al concetto della pacificazione universale, come stanno a
dimostrare le prede delle guerre giudaiche, esposte alla cittadinanza quale segno evidente
di una conquista ormai avvenuta ma anche come testimonianza di un pronto desiderio di
continuare nella pace tra i due popoli.
Le stesse opere d’arte che Nerone aveva tenuto per sé tornavano con Vespasiano alla
cittadinanza, in segno di pace interna e nel contempo come invito a godere con
l’Imperatore della grandezza dell’arte greca attraverso l’apprezzamento di
capolavori quali i gruppi dei Galati, provenienti da Pergamo, il Ganimede di Leochares,
statue di Fidia e di Policleto , dipinti di Nicomaco.
Forma Urbis Severiana
Il nucleo più imponente dei resti del Foro è tuttora nell’angolo meridionale del
sito, addossato alla Basilica di Massenzio.
E’ stato preservato dalla distruzione perché venne inglobato dalla costruzione della
chiesa dei Santi Cosma e Damiano; sono ancora leggibili tracce delle due aule alla destra
del Tempio; della prima resta la parete sud-occidentale alta circa 18 metri, sulla quale
si scorge ancora una serie di fori disposti regolarmente che sostenevano le lastre
marmoree con incisa la mappa di Roma, versione monumentale di documenti catastali del
tempo depositati negli archivi della Prefettura, collocata nel Foro da Settimio Severo nel
211.
I frammenti delle lastre , in tutto 151 divise per 11 filari, sono stati rinvenuti a
partire dal 1562 e attualmente sono conservati al Museo della Civiltà Romana in attesa di
essere definitivamente ricomposti in una sede più appropriata.
Nonostante si sia conservata in minima parte, la Forma Urbis costituisce il documento più
importante per la conoscenza della topografia dell’antica Roma.
Il Foro che non c’è
Il settore più conservato del Foro è oggi inglobato in due monumenti: la Torre dei Conti
– posta all’inizio di via Cavour, al di sotto della quale è ancora visibile la
struttura in opera quadrata di una delle esedre del portico – e la chiesa dei Santi
Cosma e Damiano, edificata tra il 526 e il 530, sull’angolo meridionale del Foro
all’interno dell’aula retrostante il muro della Forma Urbis.
Il sito era forse costituito da due ambienti: l’uno, quello retrostante la parete con
la Forma Urbis, identificato con la Biblioteca, come dimostrano le nicchie scavate
nelle pareti per ospitare armadi per libri, esattamente come nella Biblioteca del Foro di
Traiano; l’altro in origine absidato, che si appoggiò al cosiddetto Tempio di Romolo
nel Foro Romano, del quale ancora si può ammirare la parete esterna della porta di
accesso in blocchi di peperino e travertino.
Il destino del Foro della Pace richiama inevitabilmente alla mente la legge del
contrappasso dantesco: infatti, al momento della costruzione, il complesso forense
determinò la distruzione o l’inglobamento di vecchie memorie repubblicane, come il
Foro Piscario e il Macellum, grandioso mercato della Subura, mentre oggi a
differenza degli altri Fori, dei quali si può ammirare almeno una modesta porzione, Il
Foro della Pace è decisamente sopraffatto da costruzioni posteriori.
> Foro di Augusto
> Foro di Cesare
> Foro di Nerva
> Foro di Traiano
> Mercati di
Traiano
> Presentazione
dell'operazione
> Metodologie di
recupero
> News dal cantiere
dei Fori
> Lo staff impegnato nel
recupero
|